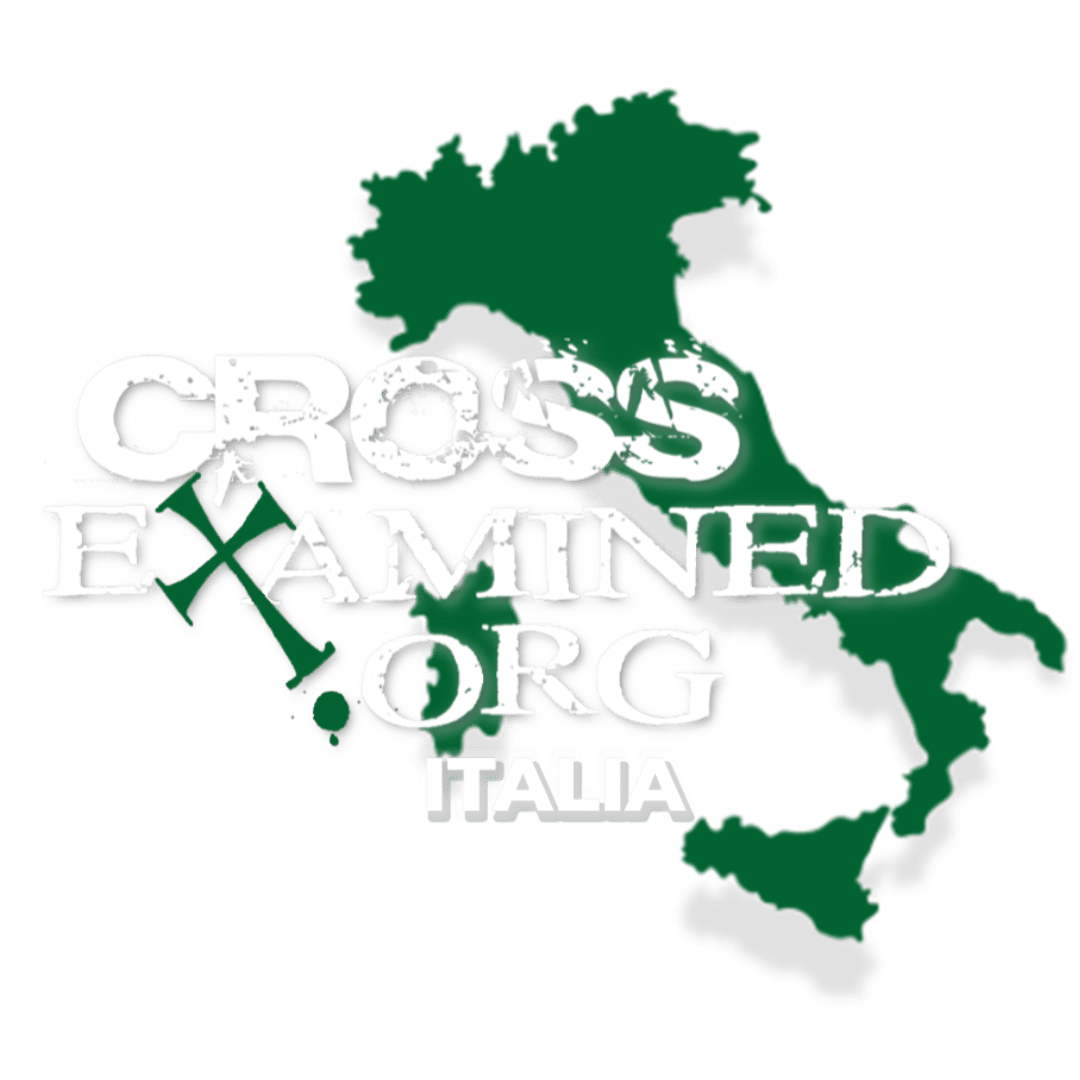Recentemente ho deciso di rileggere Science & Human Origins di Ann Gauger, Douglas Axe e Casey Luskin. Ho espresso altrove i miei dubbi sull'evoluzione darwiniana, ma ho voluto rivisitare uno dei libri più concisi e utili scritti da alcuni esperti del settore riguardo all'evoluzione umana. Per la cronaca, ho letto molti libri di darwinisti, come Why Evolution is True e "The Greatest Show on Earth” (che sono stati utili e perspicaci).
Una delle cose che apprezzo di più di Science and Human Origins è che, sebbene gli autori siano “dubitatori di Darwin”, si basano su ricerche di riviste prestigiose come Nature e su studiosi di università come Harvard, Oxford e Cambridge. È chiaro che hanno un pregiudizio (come tutti noi), ma scrivono con carità nei confronti di coloro con cui sono in disaccordo. Anche se non credi nel disegno intelligente, questo è un libro con cui vale la pena di confrontarsi (tra l'altro, è anche piuttosto corto!).
Essi rilevano cinque punti chiave sullo stato delle prove relative all'evoluzione darwiniana per quanto riguarda le origini dell'uomo. Nessuno di questi “dimostra” che l'evoluzione è falsa. Ma sono fatti importanti che spesso vengono trascurati o ignorati dalla retorica e dall'intensità che spesso circonda il dibattito sulle nostre origini:
1. I fossili individuali sono rari e incompleti. Ann Gauger osserva: “I fossili di antichi ominini sono rari e consistono tipicamente in frammenti ossei o scheletri parziali disarticolati ottenuti da diverse località del mondo e da diversi strati geologici. Si dividono in due categorie fondamentali: fossili simili a scimmie e fossili simili a ominidi. Questa discontinuità tra i tipi di fossili è ben nota. Ciononostante, i fossili ominini sono stati interpretati come prove storiche e fisiche della nostra comune ascendenza con le scimmie” (p. 17).
2. C'è poco tempo per le mutazioni necessarie. Ann Gauger osserva: “C'è abbastanza tempo per ottenere sedici cambiamenti anatomici attraverso un processo neodarwiniano? Ognuna di queste nuove caratteristiche ha probabilmente richiesto più mutazioni. Ottenere una caratteristica che richiede sei mutazioni neutre è il limite di ciò che i batteri possono produrre. Per i primati (ad esempio, scimmie, gorilla ed esseri umani) il limite è molto più rigoroso. A causa delle dimensioni effettive della popolazione molto più piccole (si stima che siano diecimila per gli esseri umani, anziché un miliardo per i batteri) e dei tempi di generazione più lunghi (quindici o vent'anni per generazione per gli esseri umani, contro un migliaio di generazioni all'anno per i batteri), ci vorrebbe molto tempo perché anche una sola mutazione benefica appaia e si fissi in una popolazione umana” (p. 24).
3. Gli esseri umani e gli scimpanzé presentano differenze genomiche significative. Douglas Axe osserva: “Un confronto dei genomi completi dell'uomo e dello scimpanzé ha identificato venti famiglie geniche distinte, ciascuna con più geni, che sono presenti nell'uomo ma assenti nello scimpanzé e in altri mammiferi” (p. 41).
4. La documentazione fossile è piuttosto scarsa. Casey Luskin osserva: “Mentre praticamente l'intera documentazione fossile sugli ominini è caratterizzata da fossili incompleti e frammentati, intorno a 3-4 mya vediamo apparire improvvisamente australopitecine scimmiesche. Quando il genere Homo appare intorno a 2mya, lo fa anch'esso in modo brusco, senza chiare prove di una transizione dai precedenti ominini scimmieschi… Ci sono molte lacune e praticamente nessun fossile di transizione plausibile che sia generalmente considerato, anche dagli evoluzionisti, un diretto antenato dell'uomo” (p. 74).
5. Adamo ed Eva non sono stati smentiti dalla genetica delle popolazioni. Per quanto riguarda l'attendibilità degli studi che si presume confutino la plausibilità di Adamo ed Eva, Ann Gauger osserva: “Le equazioni utilizzate per ricostruire questi alberi e per calcolare le dimensioni delle popolazioni ancestrali dipendono da semplificazioni e assunzioni per rendere la matematica trattabile… Queste assunzioni esplicite includono un tasso di mutazione di fondo costante nel tempo, l‘assenza di selezione per il cambiamento genetico sulle sequenze di DNA studiate, la riproduzione casuale tra gli individui, l’assenza di migrazioni all'interno o all'esterno della popolazione riproduttiva e una dimensione costante della popolazione”. Se una qualsiasi di queste ipotesi si rivela irrealistica, i risultati di un modello possono essere fortemente compromessi” (p. 112).
__________________________________________________________________________
Sean McDowell, Ph.D. , è professore di Apologetica cristiana alla Biola University, autore di best-seller, oratore popolare e insegnante part-time di scuola superiore. Seguilo su Twitter: @sean_mcdowell, TikTok, Instagram e il suo blog: seanmcdowell.org.