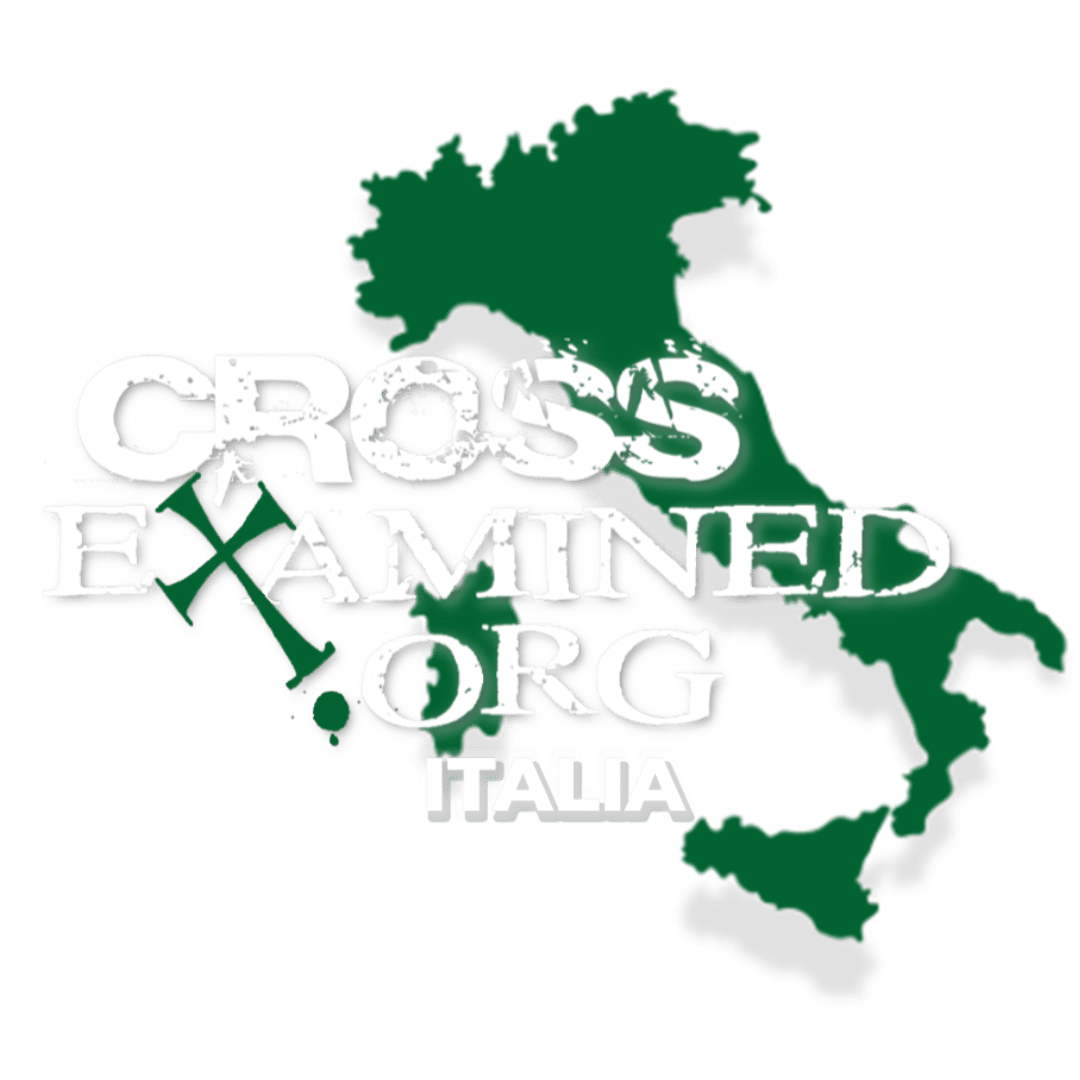La cultura moderna considera la scienza come il mezzo per eccellenza per comprendere il mondo. Se qualcosa non può essere stabilito dalla scienza, allora, secondo molti, è inconoscibile o semplicemente una questione di fede personale.
Sebbene la scienza sia un mezzo innegabilmente importante per scoprire verità sul nostro mondo e abbia contribuito notevolmente al benessere umano, non è giustificato affermare che sia l'unico – o addirittura il migliore- mezzo per conoscere la verità.
Nel suo eccellente libro “The Experience of God” (L'esperienza di Dio), il filosofo David Bentley Hart fornisce una risposta convincente all'affermazione che la scienza è l'unico mezzo per conoscere la verità:
Non pochi uomini e donne altrimenti intelligenti considerano come principio consolidato che possiamo conoscere come vero solo ciò che può essere verificato con il metodo empirico della sperimentazione e dell'osservazione. Si tratta, innanzitutto, di un'affermazione notoriamente auto-rifiutante, in quanto non può essere dimostrata vera da nessuna applicazione del metodo empirico.
Ma, soprattutto, si tratta di un'assurdità trasparente: la maggior parte delle cose che sappiamo essere vere, spesso in modo indubitabile, non rientrano nell'ambito di ciò che può essere testato con metodi empirici; sono per loro natura episodiche, esperienziali, locali, personali, intuitive o puramente logiche. Le scienze riguardano certi fatti come organizzati da certe teorie e certe teorie come vincolate da certi fatti; accumulano prove ed elaborano ipotesi all'interno di paradigmi molto rigorosamente limitati; ma non forniscono prove di dove inizi o finisca la realtà, né di quali siano le dimensioni della verità. Non possono nemmeno stabilire le proprie premesse di lavoro – la reale esistenza del mondo fisico, il potere dell'intelletto umano di riflettere accuratamente tale realtà, la perfetta legalità della natura, la sua regolarità matematica e così via – e non dovrebbero cercare di farlo, ma limitarsi alle verità a cui i loro metodi danno accesso.
Dovrebbero anche riconoscere quali sono i confini del testo scientifico. Ci sono, infatti, verità della ragione che sono di gran lunga più sicure anche delle scoperte più ampiamente supportate della scienza empirica, perché tali verità non sono, come devono sempre essere, suscettibili di una successiva revisione teorica; e poi ci sono verità della matematica che sono soggette a dimostrazione nel senso più proprio del termine e quindi sono ancora più inconfutabili. E non c'è un unico discorso sulla verità in quanto tale, non c'è un unico percorso di conoscenza della realtà, non c'è un unico metodo che possa definire in modo esaustivo che cosa sia la conoscenza, non c'è una risposta utile il cui raggio d'azione non sia stato limitato in anticipo dal tipo di domande che le hanno suscitate.
L'incapacità di rendersene conto può portare solo a deliri del tipo espresso, ad esempio, dall'affermazione auto-parodica di G.G. Simpson, secondo cui tutti i tentativi di definire il senso della vita o la natura dell'umanità fatti prima del 1859 non sono del tutto privi di valore, o dalle affermazioni assurde ed entusiastiche di Peter Atkin, secondo cui la scienza moderna può “affrontare ogni aspetto dell'esistenza” e non ha mai “incontrato una barriera”. Sentimenti di questo tipo non solo sfiorano lo squilibrio, ma sono niente meno che violenti assalti alla dignità di verità della scienza.
La scienza è un mezzo incredibilmente prezioso per conoscere il mondo. Non dovremmo mai sminuirne l'importanza. Ma, come sottolinea Hart, dovremmo anche evitare la tentazione di sopravvalutare il suo significato.
____________________________________________________________________________________
Sean McDowell, Ph.D., è professore di Apologetica cristiana alla Biola University, autore di oltre 18 libri, oratore riconosciuto a livello internazionale e insegnante part-time di scuola superiore. Seguilo su Twitter: @sean_mcdowell, TikTok, Instagram e il suo blog:seanmcdowell.org.