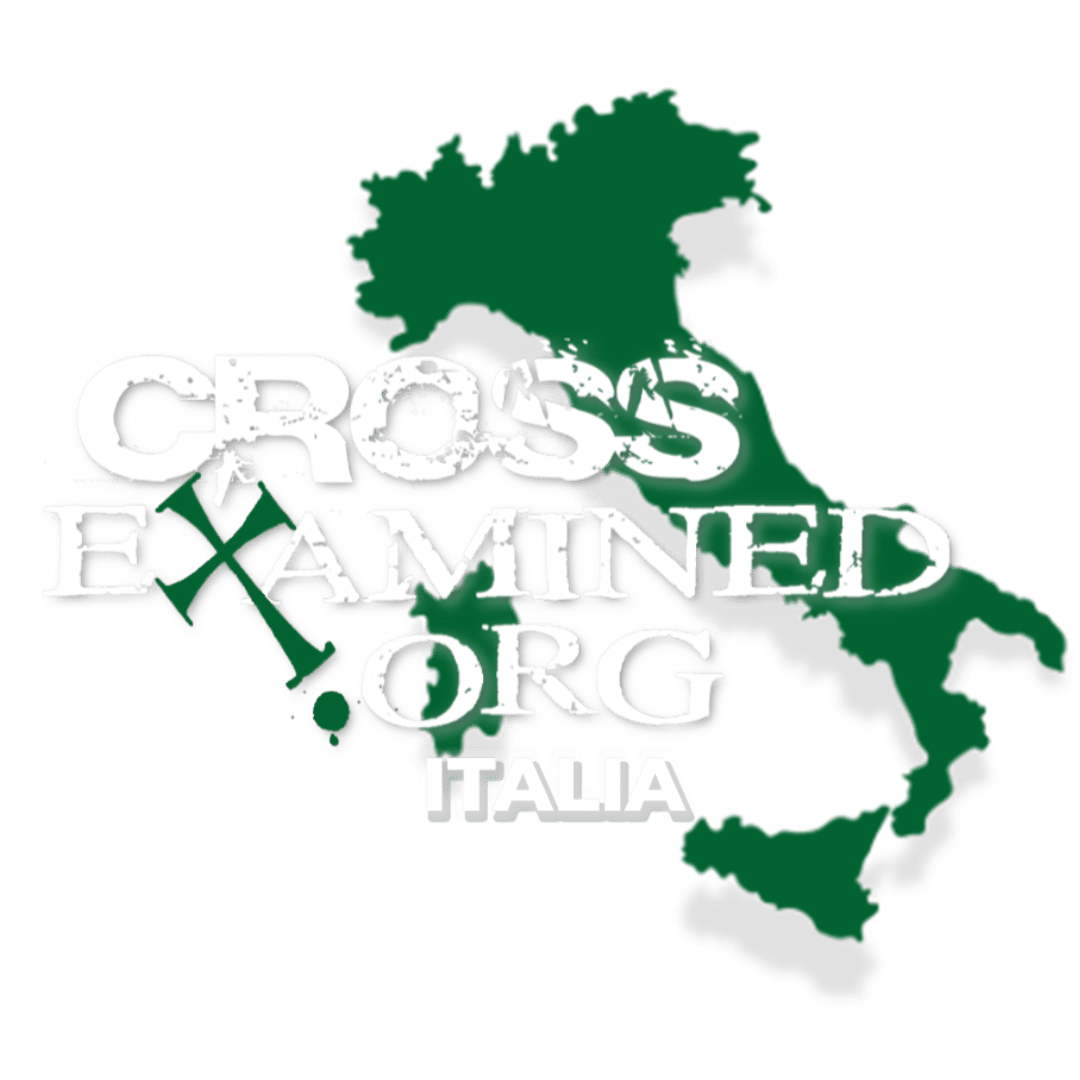L’ateismo può spiegare la moralità oggettiva?
DI RYAN LEASURE – 2 NOVEMBRE 2021
Esiste una morale oggettiva? Vale a dire, certe azioni sono giuste o sbagliate a prescindere da ciò che pensa la gente? Filosofi e scienziati morali si sono confrontati per secoli sulla questione della morale oggettiva. Prima dell’Illuminismo, la morale oggettiva era un dato di fatto. Il fondamento era la natura stessa di Dio.
A partire dall’Illuminismo, tuttavia, menti brillanti hanno cercato di trovare altre spiegazioni per la morale oggettiva utilizzando solo il mondo naturale, e questa ricerca si è rivelata piuttosto difficile. Di conseguenza, il naturalismo – il credo che nega qualsiasi realtà soprannaturale o spirituale – ha generato decine di nichilisti morali. L’ateo contemporaneo Richard Dawkins riassume bene questo punto di vista quando scrive: “L’universo che osserviamo ha esattamente le proprietà che dovremmo aspettarci se in fondo non c’è nessun disegno, nessuno scopo, nessun male e nessun bene, nient’altro che una cieca e spietata indifferenza“[1].
Molti scettici, invece, desiderano evitare una prospettiva così deprimente. Dopo tutto, l’esperienza umana sembra suggerire che alcune azioni sono oggettivamente buone o cattive. Pertanto, invece di adottare il nichilismo morale, altri naturalisti adottano il punto di vista noto come realismo morale, cercando di mantenere valori e doveri morali oggettivi.[2] Ma questa visione può reggere a un esame? I filosofi e gli scienziati sono riusciti a fondare la morale in un luogo diverso da Dio?
In questo articolo dimostrerò che il teismo è l’unica base per una morale oggettiva. Sosterrò questa tesi in due modi. In primo luogo, valuterò le diverse spiegazioni che i naturalisti hanno utilizzato per fondare la moralità e ne dimostrerò l’insufficienza. In secondo luogo, dimostrerò che il teismo spiega la morale oggettiva nonostante le obiezioni degli scettici.
Naturalismo e morale
In Lettera a una nazione cristiana, Sam Harris osserva: “Le domande sulla moralità sono domande sulla felicità e sulla sofferenza. . . . Nella misura in cui le nostre azioni possono influenzare positivamente o negativamente l’esperienza di altre creature, le questioni di moralità si applicano“[3]. Autodefinitosi ateo, Harris adotta un approccio totalitario che sostiene che possiamo fondare la moralità nel piacere o nell’infelicità degli individui.
Nel suo libro più criticato, The Moral Landscape (Lo Scenario Morale, ndr), definisce il “bene” come ciò che sostiene il benessere delle “creature coscienti”[4] Ma perché, dato l’ateismo, dovremmo pensare che il benessere degli esseri umani sia oggettivamente buono? Dove, esattamente, nel mondo naturale apprendiamo questa verità oggettiva? Harris non riesce a fornire una spiegazione per questa affermazione. Si limita a equiparare il “bene” alla “prosperità umana” senza alcuna giustificazione, in quello che è un equivoco e un ragionamento circolare.
Fallacia dell’essere/dover essere
Il tentativo di Harris di fondare la moralità sul benessere umano fallisce su almeno altri due fronti. In primo luogo, Harris è colpevole di aver commesso la fallacia dell’essere/dover essere. In generale, una persona commette la fallacia dell’essere/dover essere quando tenta di formulare giudizi di valore usando la scienza.[5] La scienza, dopo tutto, spiega solo ciò che “è”, non come le cose “dovrebbero” essere. Per esempio, la scienza ci dice come fare una bomba atomica. Tuttavia, non può dirci se dovremmo usarla. Harris ritiene di poter dimostrare il suo punto di vista dimostrando che la scienza ci dice come rendere la vita più favorevole. Ma cosa dimostra esattamente?
Certamente i progressi della scienza hanno favorito il benessere umano. La scienza ci dice anche come rendere la vita più favorevole al mais e ai conigli. Ma questo non significa che sia moralmente malvagio proibire la fioritura del mais. Poiché Harris non può fondare la moralità oggettiva come il termine è filosoficamente inteso, il suo unico ricorso è un gioco di prestigio semantico in cui ridefinisce la parola “bene” per indicare la prosperità umana. Tuttavia, sebbene la scienza ci dica come promuovere la prosperità umana, non ci dice che “dovremmo” promuovere la prosperità umana.
Determinismo naturalistico
Il secondo errore fatale dell’argomentazione di Harris è il suo impegno nel determinismo naturalistico. In quanto sostenitore di una morale oggettiva, Harris afferma che “dovremmo” agire in un certo modo. Allo stesso tempo, però, rifiuta la nozione di libero arbitrio.[6] Arriva ad affermare che il libero arbitrio è solo un'”illusione”.[7] In quanto determinista naturalistico, Harris sostiene che ogni evento è il risultato di una reazione a catena che è stata causalmente determinata dalle leggi della fisica e della chimica. In sostanza, gli esseri umani agiscono in modo robotico e non possiedono alcun controllo volitivo sulle loro azioni.
Questa posizione è fondamentale per concordare con Richard Dawkins quando afferma: “Il DNA non sa né si preoccupa. Il DNA è e basta. E noi balliamo la sua musica“[8] Ci aspettiamo che Dawkins faccia un’affermazione del genere, dal momento che nega la moralità oggettiva. Non ci aspetteremmo, invece, che Harris affermasse il determinismo, poiché ciò compromette la sua argomentazione morale. Dopo tutto, egli condanna notoriamente le persone religiose per le loro azioni concordanti. Ma dato il determinismo di Harris, può davvero biasimarli? Non crede forse che le loro azioni siano state caricate a molla al Big Bang e portate avanti dalle inflessibili leggi della fisica e della chimica?
Ragionamento naturalistico?
Il problema del determinismo di Harris è ancora più profondo. Infatti, se il naturalismo è corretto e gli esseri umani sono mera materia e nient’altro, allora il pensiero razionale diventa impossibile. La razionalità è, dopo tutto, la capacità di giudicare tra argomenti e prove. Ma come fanno gli atomi, le molecole e le leggi fisiche a prendere decisioni coscienti? Anni fa, C.S. Lewis ha riconosciuto questo difetto fatale. Egli osserva: “Una teoria che spiegasse tutto il resto dell’universo, ma che rendesse impossibile credere che il nostro pensiero sia valido, sarebbe del tutto fuori luogo. Perché quella teoria sarebbe stata raggiunta dal pensiero, e se il pensiero non è valido, quella teoria sarebbe, ovviamente, essa stessa demolita“[9]. In altre parole, se Harris ha ragione sul determinismo naturalistico, ne consegue che non abbiamo nemmeno motivi per sapere se il naturalismo è vero.[10]
In definitiva, sebbene il desiderio di Harris di affermare una moralità oggettiva sia lodevole, egli non ha alcuna base razionale per le sue affermazioni. Non solo commette la fallacia dell’essere/dover essere ma compromette anche la sua posizione negando categoricamente il libero arbitrio di qualsiasi tipo. Per queste ragioni, la visione di Harris non è riuscita ad attrarre molti pretendenti. I naturalisti, tuttavia, non hanno abbandonato del tutto l’impresa. La maggior parte dei naturalisti mira a fondare la morale in un altro modo: attraverso la biologia evolutiva.
Moralità dall’evoluzione?
L’evoluzione darwiniana standard afferma la discendenza con modificazioni. Questo processo di selezione naturale che agisce su mutazioni casuali è stato il punto di vista standard dei naturalisti per molto tempo. In superficie, questo modello sembra contraddire la nostra moderna concezione della moralità. Se Darwin aveva ragione, infatti, per milioni di anni le creature si sono fatte strada a colpi di graffi e artigli, a volte uccidendosi e mangiandosi a vicenda. Possiamo quindi capire come la selezione naturale spieghi caratteristiche come l’impulso sessuale, la fame e la paura, poiché queste qualità hanno contribuito alla conservazione. Ma come spiega la selezione naturale il fenomeno dell’altruismo? In che modo il sacrificio di se stessi per il bene degli altri aiuta la sopravvivenza?
I naturalisti offrono in genere due spiegazioni: la selezione per parentela e l’altruismo reciproco. La teoria della selezione per parentela suggerisce che le specie si comportano in modo altruistico in modo da favorire il resto della famiglia a proprie spese. Ad esempio, una scimmia potrebbe lanciare un grido di avvertimento ai suoi parenti se vede arrivare un leopardo. Questo grido fa sì che il leopardo concentri la sua attenzione su di lei, diminuendo la sua sopravvivenza. Questo sacrificio, tuttavia, assicura che i geni della famiglia – gli stessi geni condivisi dalla scimmia altruista – sopravvivano e vengano trasmessi alla generazione successiva.[11]
I naturalisti sostengono anche che l’altruismo sia nato attraverso relazioni di reciprocità. L’altruismo reciproco, che equivale a dire “tu mi gratti la schiena e io la gratto a te”, è simile al baratto, in cui le specie asimmetriche si aiutano a vicenda fornendo servizi che l’altra non può fornire da sola. Le api hanno bisogno di nettare e i fiori di impollinazione. Oppure, in alcuni casi, gli animali hanno bisogno di rimuovere insetti e sporcizia dalla loro pelliccia, quindi un altro animale lo farà per loro quando potrebbero essere alla ricerca di cibo o di un compagno. La selezione naturale, quindi, favorisce le specie che forniscono servizi ad altre specie.
Il fallimento dell’evoluzione
Anche se concediamo che l’evoluzione spieghi l’ascesa dell’altruismo, ciò non risolve il problema del naturalista per alcune ragioni. In primo luogo, se si considera l’ascesa evolutiva dell’altruismo, diventa chiaro che l’altruismo – soprattutto nel modello reciprocante – è praticato per motivi egoistici. In altre parole, la teoria suggerisce che le specie fanno cose “belle” per le altre creature solo perché ne traggono beneficio nel lungo periodo. Ma ora stiamo parlando di egocentrismo, l’esatto contrario dell’altruismo.
Una seconda critica al modello evolutivo è che rende la morale arbitraria. Vale a dire, raggiunge conclusioni ad hoc sul valore degli esseri umani. Infatti, se la teoria di Darwin è corretta, tutte le specie viventi discendono da un organismo unicellulare e ora formano i diversi rami dell’albero della vita di Darwin. Tenendo presente questo modello, chi può dire che gli esseri umani debbano essere trattati in modo diverso da grilli, ratti o mucche? William Lane Craig si riferisce a questa incoerenza come “specie-ismo“, nel senso che le persone mostrano un pregiudizio ingiustificato verso la propria specie.[12] Craig ha ragione su questo punto. Considerando il naturalismo e il modello darwiniano, gli esseri umani sono solo un ramo tra i tanti. Nulla del darwinismo ci dice che dovremmo agire in modo diverso dalle altre specie del regno animale.
Prendiamo ad esempio la vedova nera, che spesso mangia la sua controparte maschile durante il processo di accoppiamento. Oppure consideriamo gli squali maschi che copulano con la forza con gli squali femmina. Queste creature commettono forse dei mali morali? Se no, perché queste stesse azioni sarebbero sbagliate per gli esseri umani, visto che apparteniamo tutti allo stesso albero della vita? Possiamo certamente apprezzare gli umanisti secolari che desiderano sostenere che gli esseri umani hanno un valore intrinseco, ma non hanno modo di fondare questa posizione dato il loro naturalismo. Il filosofo ateo Michael Ruse lo ammette quando scrive: “Apprezzo che quando qualcuno dice: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, pensi di riferirsi al di sopra e al di là di se stesso. . . . Tuttavia, … tale riferimento è davvero privo di fondamento“[13].
La moralità evolutiva si trova su un terreno ancora più vacillante se consideriamo che l’evoluzione è, per definizione, il processo non guidato della selezione naturale. In altre parole, se dovessimo riavvolgere il tempo fino all’inizio e ricominciare da capo, la morale potrebbe essersi evoluta in modo molto diverso. La morale umana avrebbe potuto evolversi come le vedove nere e gli squali e noi non avremmo notato alcuna differenza.
La terza e più grave critica al modello evoluzionistico è che non può nemmeno iniziare a spiegare perché qualcosa sia oggettivamente giusto o sbagliato. Anche se concediamo che l’evoluzione spieghi adeguatamente come le specie abbiano iniziato ad agire in modo morale, non riesce a spiegare perché agire in quei modi sia oggettivamente buono. Allo stesso modo, i naturalisti pensano che il fatto di poter discernere la moralità significhi che hanno risolto il problema. Ancora una volta, William Lane Craig sottolinea questo difetto fatale quando esclama: “Sono rimasto stupito dalla confusione dell’ontologia morale con l’epistemologia morale da parte di importanti filosofi morali“[14].
Alla fine, i naturalisti che cercano di fondare la morale oggettiva nel mondo naturale falliscono nel loro tentativo. Potrebbero essere in grado di spiegare le origini dell’altruismo. E potrebbero anche conoscere una morale oggettiva. Ma non possono spiegare l’esistenza della norma morale stessa e perché gli esseri umani dovrebbero seguirla.
Sulla base di queste osservazioni, il naturalismo non può fondare la morale oggettiva. Allo stesso tempo, però, gli esseri umani sperimentano una certa “doverosità”. Sentono di dover amare piuttosto che odiare e di dover mostrare coraggio piuttosto che codardia. Questi “doveri” sono epistemicamente sorprendenti, dato il naturalismo. Tuttavia, corrispondono perfettamente a un’altra visione del mondo.
Teismo e Morale
La “doverosità” che gli esseri umani sperimentano si adatta perfettamente a una visione del mondo teistica. Sebbene l’argomentazione non dipenda dalla visione del mondo teista che si abbraccia, questa sezione affronterà l’argomento a partire dalla visione del mondo cristiana.
I Cristiani sostengono che la moralità oggettiva è fondata su Dio stesso. Il fatto che i naturalisti non riescano a fondare la morale nel mondo naturale avvalora ulteriormente la tesi Cristiana secondo cui la legge morale deve derivare da una fonte diversa, ossia soprannaturale.
Affrontare Eutifrone
Un’obiezione popolare alla posizione Cristiana è comunemente indicata come il dilemma di Eutifrone. Questo dilemma è stato sollevato per la prima volta nel dialogo di Platone e recita così: o qualcosa è buono perché Dio l’ha voluto o Dio vuole qualcosa perché è buono.
Si noti il dilemma che queste alternative sollevano per la visione teistica. Infatti, se qualcosa è buono perché Dio l’ha voluto, ne consegue che ciò che è buono è arbitrario. D’altra parte, se Dio vuole qualcosa perché è buono, allora lo standard morale esiste indipendentemente da Dio.
Il problema di questa obiezione, tuttavia, è che lo scettico presenta al teista un falso dilemma. Esiste, cioè, una terza opzione che afferma che Dio vuole perché è buono. Questa visione sostiene che i comandi di Dio, lungi dall’essere arbitrari, sono radicati nella sua natura perfettamente buona. O, per dirla in altro modo, i comandi di Dio sono “espressioni necessarie della sua natura giusta e amorevole“[15]. Anche C.S. Lewis è stato perspicace a questo proposito. Ha dichiarato: “La volontà di Dio è determinata dalla sua saggezza che percepisce sempre, e dalla sua bontà che abbraccia sempre, l’intrinsecamente buono“[16]. Alla fine, il Dilemma di Eutifrone non è poi così tanto un dilemma.
Relativismo
Un’altra obiezione popolare alla visione teista è che le verità morali sono relative. I relativisti concordano sul fatto che il naturalismo non può fondare una morale oggettiva, ma si spingono oltre suggerendo che la morale oggettiva non esiste affatto. Per sostenere questa affermazione, i relativisti fanno riferimento a ciò che percepiscono come standard morali diversi nelle varie culture. Tuttavia, la posizione relativista fallisce su più fronti.
In primo luogo, i relativisti spesso confondono la moralità oggettiva con il cambiamento del comportamento. Ad esempio, sostengono che, poiché la cultura occidentale riteneva accettabile la schiavitù, mentre ora non lo è più, la morale deve essere cambiata. Questa argomentazione, tuttavia, non è troppo diversa dalla fallacia “essere/dover essere” di Sam Harris. La semplice descrizione del cambiamento nel comportamento umano non dimostra in alcun modo che la moralità oggettiva sia cambiata. Questo punto di vista equivale a suggerire che le leggi della fisica sono cambiate dopo Newton perché ora abbiamo una visione più illuminata.
Una seconda obiezione riguarda i disaccordi morali. Se esiste una legge morale, perché c’è tanto disaccordo sulle questioni morali? Anche in questo caso, l’obiezione dei relativisti è debole.
Consideriamo il moderno dibattito sull’aborto. Una visione ritiene che sia un crimine morale, in quanto ritiene che l’aborto sia l’omicidio di un bambino innocente. D’altra parte, coloro che sono a favore della scelta pensano che l’aborto sia accettabile se è ciò che la madre sceglie. La tattica dei pro-scelta, tuttavia, è quella di ridefinire ciò che esiste nel grembo della madre. Usano frasi eufemistiche come “grumo di cellule” piuttosto che “bambino” per giustificarne l’uccisione. Questo cambiamento di terminologia suggerisce che entrambe le parti concordano sul principio morale di base che l’omicidio è sbagliato. Una posizione, però, ha cambiato la terminologia per giustificare il proprio punto di vista.
Questo cambiamento terminologico non è molto diverso da come i nazisti giustificarono l’Olocausto o da come gli americani coloniali giustificarono la schiavitù. In entrambi i casi, si sono convinti di non avere a che fare con esseri umani di pari valore, nel tentativo di tranquillizzare le loro coscienze. Così, mentre in superficie sembra che esistano ampi disaccordi morali tra persone e culture, un esame più attento mostra che le questioni morali di fondo sono piuttosto simili. Lewis osserva: “Se qualcuno si prenderà la briga di confrontare gli insegnamenti morali, ad esempio, degli antichi egizi, babilonesi, indù, cinesi, greci e romani, ciò che lo colpirà sarà quanto siano simili tra loro e ai nostri“[17]. Questa moralità comunemente intesa spiega perché i codici giuridici e i codici religiosi abbiano molto in comune in ogni epoca e cultura.
Portatori di immagine e libero arbitrio
Data la posizione cristiana, come si spiega questo senso comune della moralità? La risposta è radicata nella creazione dell’uomo da parte di Dio. Nel primo capitolo della Bibbia, leggiamo che Dio ha fatto gli esseri umani a sua immagine e somiglianza, come apice della sua creazione (Genesi 1:26-27). In quanto portatori della immagine di Dio, gli esseri umani condividono alcune caratteristiche con il Divino. Poiché il teismo classico afferma che Dio è un essere massimamente grande e che parte della sua massima grandezza è la sua perfetta bontà, non ci sorprende che gli esseri umani desiderino fare il bene.
Inoltre, la lotta perpetua sulle questioni etiche coincide anche con il teismo. Per esempio, se il naturalismo fosse vero, gli esseri umani agirebbero semplicemente in base al loro impulso più forte, determinato dalle leggi della chimica nel loro cervello. Ma gli esseri umani non agiscono in questo modo – o almeno sanno che non dovrebbero farlo. Anche i naturalisti riconoscono che non dovremmo agire in base ai nostri impulsi più forti quando questi impulsi ci porterebbero a uccidere, stuprare o rubare. Eppure, questa capacità di astenersi dall’agire secondo i propri impulsi più forti sarebbe impossibile per il naturalismo. Ma se Dio ha creato le persone sia materiali che immateriali, ne consegue che esse possono decidere tra desideri contrastanti.
C.S. Lewis, contemplando proprio questo problema, suggerì: “Se due istinti sono in conflitto, e nella mente di una creatura non c’è altro che questi due istinti, ovviamente deve vincere il più forte dei due. Ma nei momenti in cui siamo più consapevoli della Legge Morale, questa di solito sembra dirci di stare dalla parte del più debole dei due impulsi. Probabilmente volete essere al sicuro più di quanto vogliate aiutare l’uomo che sta annegando: ma la Legge Morale vi dice di aiutarlo lo stesso“[18].
Lewis riconosceva che nelle persone c’è qualcosa di più della semplice chimica fisica. Le persone possiedono la capacità di prendere decisioni volitive contrarie ai loro impulsi più forti. E come suggerisce Lewis, le persone lo fanno perché sono intrinsecamente consapevoli della legge morale. Per lui, la sensazione che dovremmo comportarci in un certo modo e il senso di colpa che ne consegue quando non rispettiamo questo standard morale suggeriscono che esiste una legge morale e che siamo stati programmati per vivere alla luce di questa legge.[19]
Legge morale
Questi sentimenti sono condivisi da tutti gli uomini, perché tutti sono fatti a immagine di Dio, indipendentemente dalla loro fede. L’apostolo Paolo lo riconosce quando scrive: “Infatti, quando i pagani, che non hanno la legge, fanno per natura ciò che la legge richiede, sono legge a se stessi, anche se non hanno la legge. Mostrano che l’opera della legge è scritta sul loro cuore, mentre anche la loro coscienza ne dà testimonianza e i loro pensieri contrastanti li accusano o addirittura li scusano” (Romani 2:14-15).
Secondo Paolo, i Gentili – coloro che non hanno la legge scritta – sono ancora responsabili del loro peccato per due motivi distinti. In primo luogo, Dio ha impiantato in loro la sua legge morale. In secondo luogo, ha dato a tutti una coscienza con la quale possono discernere se stanno vivendo in conformità a quella legge morale. È fondamentale distinguere tra le due cose. Per quanto riguarda la legge morale, lo studioso del Nuovo Testamento Douglas Moo sostiene che “Paolo sta quasi certamente mettendo in atto una diffusa tradizione greca secondo la quale tutti gli esseri umani possiedono una legge “non scritta” o “naturale”, un senso morale innato di “giusto e sbagliato”“[20].
Moo prosegue sostenendo che la coscienza è “un meccanismo riflessivo con cui le persone possono misurare la loro conformità a una norma“[21]. Thomas Schreiner concorda con questa valutazione. Egli sostiene che “identificare la coscienza e la legge, in modo che entrambe siano intese come fonte di norme morali, è sbagliato. La coscienza non è l’origine delle norme morali, ma giudica se una persona si è attenuta a tali norme“[22] Pertanto, la ragione per cui le persone sperimentano il “dovere” è duplice. In primo luogo, Dio ha impiantato la sua legge morale in tutti gli uomini. In secondo luogo, ha instillato in tutti una coscienza che accusa o giustifica le loro azioni.
Perciò, il teismo ci dà una solida base per i valori morali oggettivi. Spiega lo standard morale oggettivo che esiste nel nostro universo – lo stupro è male – e spiega perché le persone sentono di dover agire in un certo modo.
Conclusione
Come dimostrato da questo articolo, il teismo è l’unica base per una moralità oggettiva. Poiché il naturalismo non riesce a fornire un fondamento oggettivo per la morale, le uniche opzioni rimaste sono il nichilismo morale o la convinzione che Dio sia il fondamento della morale. Gli atei che vogliono negare l’esistenza di Dio, quindi, devono ricorrere a posizioni radicalmente nichiliste, negando persino il male oggettivo di eventi come l’Olocausto.
L’esperienza ci dice, però, che questa prospettiva è invivibile. Infatti, se quegli stessi relativisti fossero stati costretti a entrare in quelle camere a gas, avrebbero rapidamente abbracciato la moralità oggettiva. In effetti, le persone sono solitamente in grado di discernere la morale oggettiva in base al modo in cui gli altri le trattano. Se qualcuno violenta la propria figlia o incendia la propria casa, diranno cose come “non è giusto” o “non è equo”, senza pensare alle implicazioni in termini di visione del mondo di tali affermazioni. Sebbene molti scettici sostengano che la nostra percezione della realtà sia solo un’illusione, la soluzione migliore è adottare la visione del mondo che meglio spiega le nostre esperienze.
—————————————————————
[1] Richard Dawkins, River Out of Eden (New York: Basic Boosk, 1995), 133.
[2] J. P. Moreland e William Lane Craig, Philosophical Foundations for a Christian Worldview (Downers Grove, IL: IVP Press, 2003), 492.
[3] Sam Harris,Letter to a Christian Nation (Lettera a una nazione cristiana) New York: Vintage Books, 2008, 8.
[4] Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values (New York: Free Press, 2010), 12.
[5] James Davison Hunter e Paul Nedelisky, Science and the Good: The Tragic Quest for the Foundations of Morality (New Haven, CT: Yale University Press, 2018), 18.
[6] Sam Harris,The Moral Landscape, 104.
[7] Sam Harris,The Moral Landscape, 112.
[8] Richard Dawkins, River Out of Eden, 133.
[9] C. S. Lewis, Miracles, 21-22.
[10] Si veda uno sviluppo più recente di questo argomento in Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief (New York: Oxford University Press, 2000), 227-240.
[11] Richard Dawkins, The God Delusion (L’Illusione di Dio) New York: Mariner Books, 2008), 247.
[12] William Lane Craig, Reasonable Faith: Cristian Truth and Apologetics (Fede ragionevole: Verità Cristiana e Apologetica), 3a ed. Wheaton, IL: Crossway, 2008, 175.
[13] Michael Ruse, “Evolutionary Theory and Christian Ethics”, in The Darwin Paradigm (Teoria Evolutiva e Etica Cristiana: nel Paradigma di Darwin) London: Routledge, 1989, 268-269.
[14] William Lane Craig,Reasonable Faith, 176.
[15] William Lane Craig, Reasonable Faith, 182.
[16] C. S. Lewis, The Problem of Pain, 100.
[17] C. S. Lewis, Mere Christianity (Il Cristianesimo così com’è), 5-6.
[18] C. S. Lewis, Mere Christianity, (Il Cristianesimo così com’è) New York: Harper One, 1952, 10.
[19] C. S. Lewis, Mere Christianity,(Il Cristianesimo così com’è), 8.
[20] Moo, Douglas, The Epistle to the Romans: The New International Commentary on the New Testament ( L’Epistola ai Romani: Il Nuovo Commentario Internazionale del Nuovo Testamento), Grand Rapids, Eerdmans, 1996), 150.
[21] Moo, Douglas, L’epistola ai Romani, 152-153.
[22] Schreiner, Thomas R. Romans: Baker Exegetical Guide on the New Testament (Grand Rapids: Baker, 1998), 123.