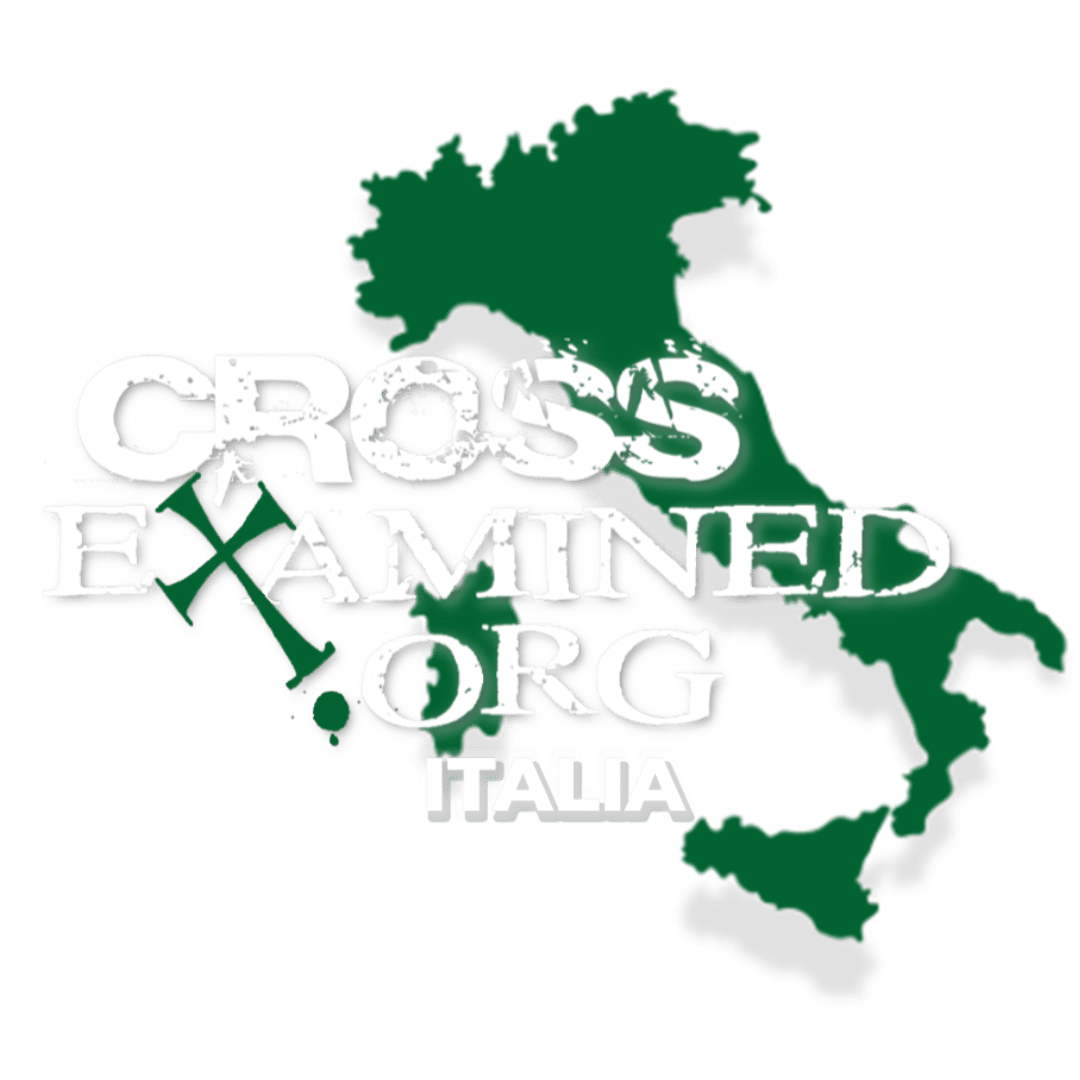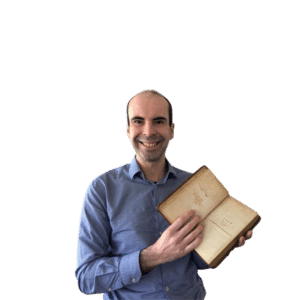Perché gli apologeti hanno bisogno di una mentalità esplorativa?
Vi siete mai chiesti perché alcune persone sono in grado di pensare al mondo in modo più chiaro, formando opinioni più equilibrate e sfumate su argomenti controversi, rispetto ad altre? Vi siete mai chiesti quali siano gli schemi di pensiero più favorevoli a un buon ragionamento e a conclusioni ben sostenute, e come si possano evitare le insidie dei pregiudizi di conferma e dell’autoinganno? Nel suo libro The Scout Mindset: Why Some People See Things Clearly and Others Don’t (La mentalità esplorativa: Perché alcune persone vedono le cose chiaramente ed altre no, ndr), Julia Galef (conduttrice del podcast “Rationally Speaking” e cofondatrice del Center for Applied Rationality) cerca di rispondere a queste domande[1]. Nella prima parte di questo saggio, riassumerò le intuizioni della Galef; nell’ultima parte, discuterò quali lezioni noi, come studiosi e apologeti cristiani, possiamo trarre dal libro.
Sintesi della mentalità esplorativa
Mentalità del soldato e Mentalità dell’esploratore a confronto
La Galef distingue tra quella che chiama “mentalità del soldato” e “mentalità dell’esploratore”. Secondo la Galef, la mentalità del soldato, nota anche come ragionamento motivato, ci porta a difendere lealmente la roccaforte delle nostre convinzioni contro le minacce intellettuali, qualunque cosa accada. Questo comporta la ricerca attiva di dati che tendono a confermare le nostre convinzioni, mentre razionalizziamo o ignoriamo i dati contrari che tendono a disconfermarle. D’altra parte, la mentalità dell’esploratore cerca di determinare onestamente come il mondo è realmente – come la definisce Galef, la mentalità esplorativa è “la motivazione a vedere le cose come sono, non come si vorrebbe che fossero” (p.9).
Per chi ha una mentalità da soldato, sostiene Galef, il ragionamento è come un combattimento difensivo: “è come se fossimo soldati che difendono le proprie convinzioni da prove minacciose” (p.7). Per il soldato, cambiare idea – ammettere di aver sbagliato – è visto come una resa e un fallimento, un segno di debolezza. La lealtà è verso le proprie convinzioni più care che verso la verità, anche se queste convinzioni sono in conflitto con l’equilibrio delle prove. Per il soldato, la determinazione di cosa credere avviene chiedendosi “Posso crederci?” o “Devo crederci?”, a seconda delle motivazioni. Per chi ha una mentalità esplorativa, invece, il ragionamento può essere paragonato alla creazione di una mappa, e scoprire di essere in errore su una o più convinzioni significa semplicemente rivedere la mappa. Pertanto, gli esploratori sono più propensi a cercare e considerare attentamente i dati che tendono a minare le proprie convinzioni (rendendo così la propria mappa un riflesso più accurato della realtà), ritenendo più proficuo prestare attenzione a coloro che non sono d’accordo con le proprie opinioni piuttosto che a coloro il cui pensiero si allinea con loro.
La prevalenza della mentalità del soldato nella società odierna è giustamente dimostrata da uno studio preoccupante, citato da Galef, in cui i partecipanti sono stati messi alla prova per quanto riguarda la loro “intelligenza scientifica” con una serie di domande[2]. Le domande erano suddivise in quattro categorie: fatti fondamentali, metodi, ragionamento quantitativo e riflessione cognitiva. È sorprendente notare che, quando ai partecipanti conservatori repubblicani e liberaldemocratici è stato chiesto anche se affermavano l’affermazione che esistono “prove solide” del recente riscaldamento globale dovuto “principalmente” all'”attività umana come la combustione di combustibili fossili”, è stata riscontrata una correlazione positiva tra “intelligenza scientifica” e opinioni divergenti. In altre parole, più alta è l’intelligenza scientifica di una persona, più è probabile che un democratico liberale affermi l’affermazione e più è probabile che un repubblicano conservatore sia in disaccordo con essa. Questo non è l’unico studio che rivela la tendenza delle persone più istruite a divergere nelle opinioni su argomenti controversi. Un altro studio ha esaminato le opinioni delle persone su argomenti di natura ideologica, tra cui la ricerca sulle cellule staminali, il Big Bang, l’evoluzione umana e il cambiamento climatico[3]. Il risultato è stato che “gli individui con maggiore istruzione, educazione scientifica e alfabetizzazione scientifica mostrano convinzioni più polarizzate su questi temi”, anche se hanno trovato “poche prove di polarizzazione politica o religiosa per quanto riguarda le nanotecnologie e gli alimenti geneticamente modificati”. Galef riassume le implicazioni di questi studi: “Questo è un risultato di importanza cruciale, perché essere intelligenti ed essere competenti su un particolare argomento sono altri due elementi che ci danno un falso senso di sicurezza nei nostri ragionamenti. Un alto quoziente intellettivo e una laurea avanzata possono darvi un vantaggio in ambiti ideologicamente neutrali come la risoluzione di problemi matematici o la scelta di dove investire i vostri soldi. Ma non vi proteggeranno da pregiudizi su questioni ideologicamente cariche” (p.48).
Sebbene ci sia un elemento da esploratore e da soldato in tutti noi, sostiene Galef, “alcune persone, in alcuni contesti, sono migliori esploratori della maggior parte”, essendo “più genuinamente desiderosi della verità, anche se non è quella che speravano, e meno disposti ad accettare argomentazioni sbagliate che si rivelano convenienti”. Sono più motivati a uscire, a testare le loro teorie e a scoprire i loro errori. Sono più consapevoli della possibilità che la loro mappa della realtà possa essere sbagliata e più aperti a cambiare idea” (pp. 14-15). Sul rovescio della medaglia, spesso “usiamo il ragionamento motivato non perché non sappiamo fare di meglio, ma perché stiamo cercando di proteggere cose che sono di vitale importanza per noi: la nostra capacità di sentirci bene con la nostra vita e con noi stessi, la nostra motivazione a provare cose difficili e a continuare a farle, la nostra capacità di apparire bravi e di persuadere, e la nostra accettazione nelle nostre comunità” (p.26). Ad esempio, se siamo onesti, quante volte, nel considerare un’affermazione, ci chiediamo implicitamente: “Che tipo di persona crederebbe a un’affermazione del genere, ed è così che voglio che gli altri mi vedano?”” (p.23). Questo pensiero alimenta la mentalità del soldato. In pratica, non possiamo eliminare completamente la mentalità del soldato dai nostri processi di ragionamento. Dopo tutto, è la nostra mentalità di base. Per natura, ci piace che le nostre convinzioni vengano confermate. Ma possiamo fare dei passi intenzionali per coltivare maggiormente una mentalità da esploratore.
Le caratteristiche della Mentalità da Esploratore
Quali sono alcune delle caratteristiche chiave che distinguono la mentalità dell’esploratore da quella del soldato? Nel quarto capitolo, Galef fornisce cinque caratteristiche che definiscono un esploratore. La prima è la capacità di dire agli altri quando ci si rende conto che avevano ragione. Galef mette in guardia su questa qualità osservando che “tecnicamente, la mentalità esplorativa richiede solo la capacità di riconoscere a se stessi di aver sbagliato, non agli altri. Tuttavia, la disponibilità a dire ‘ho sbagliato’ a qualcun altro è un forte segno di una persona che privilegia la verità rispetto al proprio ego”. La seconda qualità è reagire bene alle critiche. Galef spiega: “Per valutare il vostro comfort con le critiche, non basta chiedersi: “Sono aperto alle critiche?”. Esaminate invece i vostri precedenti. Ci sono esempi di critiche a cui avete dato seguito? Avete premiato un critico (ad esempio, promuovendolo)? Vi fate in quattro per rendere più facile agli altri criticarvi?” (p.52). La terza qualità che contraddistingue un esploratore è la capacità di dimostrare che si sbaglia. Galef chiede: “Ti viene in mente qualche esempio in cui hai dimostrato volontariamente di avere torto? Forse stavate per esprimere un’opinione online, ma avete deciso di cercare prima le controargomentazioni e avete finito per trovarle convincenti. O forse al lavoro stavate sostenendo una nuova strategia, ma avete cambiato idea dopo aver analizzato più attentamente i numeri e vi siete resi conto che non sarebbe stata realizzabile” (p.54). La quarta caratteristica della mentalità esplorativa consiste nell’evitare di distorcere le proprie informazioni. “Per esempio”, scrive Galef, “quando chiedete a un amico di dire la sua opinione su un litigio che avete avuto con il vostro partner, descrivete il disaccordo senza rivelare da che parte stavate, in modo da evitare di influenzare la risposta del vostro amico? Quando lanciate un nuovo progetto al lavoro, decidete in anticipo cosa sarà considerato un successo e cosa un fallimento, in modo da non essere tentati di spostare gli obiettivi in un secondo momento?” (p.56). La quinta caratteristica elencata da Galef è la capacità di riconoscere i buoni critici. Galef commenta: “Si è tentati di considerare i propri critici come meschini, male informati o irragionevoli. Ed è probabile che alcuni di loro lo siano. Ma è improbabile che lo siano tutti. Potete citare le persone che criticano le vostre convinzioni, la vostra professione o persino le vostre scelte e che voi considerate riflessive, anche se credete che si sbaglino? Oppure potete almeno indicare i motivi per cui qualcuno potrebbe essere in disaccordo con voi e che voi considerereste ragionevoli (anche se non conoscete persone specifiche che hanno queste opinioni)?” (p.57). In sintesi, Galef osserva: “Essere in grado di nominare critici ragionevoli, essere disposti a dire “Questa volta l’altra parte ha ragione”, essere disposti a riconoscere quando si è sbagliato: sono cose come queste che distinguono le persone che si preoccupano davvero della verità da quelle che pensano solo di farlo” (p.57).
Il capitolo 5 del libro offre cinque test per verificare la presenza di pregiudizi nei nostri ragionamenti. Il primo è il test del doppio standard, che chiede essenzialmente se applichiamo a noi stessi gli stessi standard che applicheremmo agli altri. Il secondo test è quello dell’estraneo, che cerca di determinare come si valuterebbe la stessa situazione o gli stessi dati se non si avesse un interesse personale nel risultato. Il terzo test è quello della conformità, che cerca di capire fino a che punto la propria opinione è effettivamente propria. Galef spiega: “Se mi trovo d’accordo con il punto di vista di qualcun altro, faccio un test di conformità: Immaginate che questa persona mi dica che non è più d’accordo con questo punto di vista. Continuerei a sostenerlo? Mi sentirei a mio agio nel difenderlo di fronte a loro?”(p.66). Il quarto test è quello dello scetticismo selettivo: “Immaginate che questa prova sostenga l’altra parte. Quanto la troveresti credibile?” (p.68). L’ultimo test è quello dello status quo pregiudiziale: “Immaginate che la vostra situazione attuale non sia più lo status quo. La scegliereste attivamente? Se non lo fate, è segno che la vostra preferenza per la vostra situazione non riguarda tanto i suoi meriti particolari quanto la preferenza per lo status quo” (p.69).
La mentalità da esploratore rivede le convizioni con apertura e incrementi!
Un altro elemento che contraddistingue un esploratore, secondo Galef, è l’atteggiamento nei confronti dell’errore. Gli esploratori, spiega Galef, “rivedono le loro opinioni in modo incrementale nel tempo, il che rende più facile essere aperti alle prove contro le loro convinzioni” (p.144). Inoltre, “considerano gli errori come opportunità per affinare la loro abilità nel fare le cose per bene, il che fa sì che l’esperienza di rendersi conto che ‘ho sbagliato’ sia preziosa, piuttosto che solo dolorosa” (p.144). Galef suggerisce addirittura di abbandonare del tutto il concetto di “confessione di errore” e di parlare invece di “aggiornamento”. Galef spiega: “Un aggiornamento è di routine. Di basso profilo. È l’opposto di una confessione di peccato esagerata. Un aggiornamento rende qualcosa migliore o più attuale senza implicare che la sua forma precedente fosse un fallimento” (p.147). Galef sottolinea che non dovremmo pensare al cambiamento di idea come a una cosa binaria, ma piuttosto dovremmo pensare al mondo in “sfumature di grigio” e pensare al cambiamento di idea in termini di “spostamento incrementale” (p.140). Galef osserva che pensare di rivedere le proprie convinzioni in questo modo rende “l’esperienza di incontrare prove contro una delle proprie convinzioni molto diversa”, poiché “ogni aggiustamento è relativamente poco impegnativo” (p.140). Per esempio, “se siete sicuri all’80% che l’immigrazione sia un bene per l’economia e viene fuori uno studio che dimostra che l’immigrazione abbassa i salari, potete abbassare la vostra fiducia nella vostra convinzione al 70%” (p.140).
Galef sottolinea anche che, quando si tratta di esporsi intenzionalmente a contenuti che rappresentano “l’altra parte” di un dibattito a cui siamo interessati, si tende a commettere l’errore di finire sempre per “ascoltare le persone che iniziano a essere in disaccordo con noi, così come le figure pubbliche e i media che sono i rappresentanti più popolari dell’altra parte” (p.170). Tuttavia, come spiega Galef, “questi non sono criteri di selezione molto promettenti. Prima di tutto, qual è il tipo di persona che ha più probabilità di iniziare un disaccordo? Una persona sgradevole. (Esempio: “Questo articolo che hai condiviso su Facebook è una stupidaggine – lascia che ti istruisca…”). In secondo luogo, che tipo di persone o di media hanno la probabilità di diventare rappresentanti popolari di un’ideologia? Quelli che fanno il tifo per la loro parte e deridono o fanno la caricatura dell’altra parte, cioè voi” (p.170-171). Invece, Galef suggerisce: “Per avere le migliori possibilità di imparare dal disaccordo, dovreste ascoltare persone che rendono più facile l’apertura alle loro argomentazioni, non più difficile. Persone che vi piacciono o che rispettate, anche se non siete d’accordo con loro. Persone con cui avete un terreno comune – premesse intellettuali o un valore fondamentale che condividete – anche se siete in disaccordo con loro su altre questioni. Persone che considerate ragionevoli, che riconoscono sfumature e aree di incertezza e che discutono in buona fede” (p.171).
Lezioni che possiamo trarre dalla mentalità esplorativa
In che misura noi, come studiosi e apologeti cristiani, coltiviamo una mentalità esplorativa? Troppo spesso i dibattiti tra teisti e atei si trasformano in tribalismo, in una mentalità “noi contro loro” e in una compiaciuta condiscendenza nei confronti di coloro che non sono d’accordo con noi. Ma cosa succederebbe se vedessimo coloro con cui non siamo d’accordo non come nemici, ma come colleghi nella nostra ricerca di una migliore mappa della realtà? I nostri critici sono coloro che si trovano nella posizione migliore per scoprire le falle del nostro ragionamento, che possono essere invisibili per noi. Li ignoriamo a nostro rischio e pericolo. Ascoltando attentamente i nostri critici, possiamo costruire una visione del mondo più sfumata e più solida. E quali sono i critici della nostra fede che cerchiamo per rappresentare la visione dissenziente? Ci rivolgiamo principalmente a critici del cristianesimo popolari ma poco approfonditi, oppure cerchiamo attivamente i migliori, i più eruditi e i più informati critici della nostra fede, anche se meno conosciuti? Possiamo indicare alcuni dei nostri critici come onesti e riflessivi? Come ci stiamo posizionando per essere nel miglior modo possibile per scoprire che ci stiamo sbagliando, se effettivamente ci stiamo sbagliando? Se ci sbagliamo su una o più delle nostre convinzioni, possiamo dire onestamente che teniamo alla verità tanto da volerla conoscere? In che modo le nostre risposte alle domande precedenti influiscono su quest’ultima domanda?
Forse a questo punto è opportuno chiarire cosa sia esattamente l’apologetica, poiché purtroppo c’è molta confusione intorno a questa parola, sia all’interno che all’esterno della comunità cristiana. Comunemente si pensa che l’esercizio dell’apologetica sia contrario a un’indagine aperta, in cui la conclusione non è stabilita a priori. Tuttavia, questo punto di vista è del tutto errato. Sebbene l’apologetica non sia identica all’indagine aperta, è coestensiva con essa, nel senso che l’apologetica è ciò che accade dopo che i risultati dell’indagine aperta sono stati raggiunti ed è giunto il momento di rendere pubblica la nostra interpretazione dei dati. Quindi, anche se il termine è raramente usato in questo contesto, ogni pubblicazione di un documento scientifico è un esercizio di apologetica. L’Origine delle specie di Charles Darwin è stato un esercizio di apologetica, poiché ha cercato di vendere la sua interpretazione delle osservazioni che aveva fatto sulle isole Galapagos. Si è soliti pensare agli apologeti come a un avvocato penalista che si impegna a difendere il proprio cliente, in ogni caso. In realtà, però, un parallelo più azzeccato è quello di un giornalista d’inchiesta, che riporta per il consumo popolare i risultati di un’indagine equa ed equilibrata.
Benefici di una Mentalità da Esploratore per gli Apologeti Cristiani
Essere un apologeta del Vangelo non è una responsabilità leggera. Chiediamo alle persone di giurare fedeltà a Gesù Cristo e di dedicare ogni aspetto della loro vita al suo servizio. Questo può costare molto, persino la vita. Il peso di questa responsabilità è sottolineato dallo stesso apostolo Paolo, il quale afferma che, se Gesù non è stato effettivamente risuscitato, “si scopre addirittura che noi travisiamo Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che ha risuscitato Cristo, il quale non ha risuscitato se è vero che i morti non risuscitano” (1 Corinzi 15:15). Abbiamo quindi il dovere, nei confronti di coloro ai quali predichiamo, di studiare diligentemente i fatti e le argomentazioni di entrambe le parti del dibattito per assicurarci che il Vangelo sia effettivamente vero. Abbiamo anche il dovere, nei confronti di coloro con cui condividiamo il Vangelo, di informarli pienamente e completamente, per quanto possibile, sui fatti del caso. Troppo spesso ho visto apologeti presentare argomenti popolari a favore del cristianesimo, ma omettere fatti rilevanti che minano la forza delle loro argomentazioni. Per alcuni esempi, si veda la mia recente conversazione con Wesley Huff sugli argomenti che i cristiani non dovrebbero usare. Ogni volta che vi imbattete in un argomento che sostiene una posizione che vi piace, dovreste sempre, prima di ripetere pubblicamente l’argomento, condurre una ricerca approfondita di qualsiasi dato rilevante che possa ridurre la forza probatoria dell’argomento. Come minimo, dovreste verificare se qualche pubblicazione accademica, soprattutto se critica nei confronti delle vostre convinzioni, abbia già affrontato l’argomento. Questo è solo uno dei tanti modi in cui potete ridurre gli effetti negativi del pregiudizio di conferma sul vostro ragionamento.
Quali altri accorgimenti possiamo adottare per evitare i pregiudizi di conferma? Cerco di avere l’abitudine di espormi a un maggior numero di materiale – che si tratti di libri, articoli, podcast, video o altri mezzi di comunicazione – che sostiene le mie convinzioni rispetto a quelli che le sostengono. Questo riduce la probabilità di ingannare me stesso e mi costringe a riflettere più a fondo e con maggiore attenzione sulle mie convinzioni e a svilupparne un’espressione più sfumata. Inoltre, mi mette in una posizione di forza per scoprire che mi sto sbagliando, se in effetti mi sbaglio su una qualsiasi delle mie convinzioni. Un primo passo per uscire dalla propria camera d’eco intellettuale può essere quello di riconoscere che le persone intelligenti possono discutere in buona fede e tuttavia non essere d’accordo con voi.
A volte mi viene chiesto come un nuovo arrivato ai dibattiti religiosi possa discernere quali apologeti ascoltare e quali ignorare. Naturalmente, la difficoltà sta nel fatto che, per poter discernere quali apologeti siano affidabili, bisogna aver già raggiunto un certo livello di conoscenza dell’argomento. Ma per arrivare a questa soglia di conoscenza dell’argomento, bisogna prima stabilire da chi ricevere le informazioni. Come sfuggire a questo dilemma? Un criterio che spesso fornisco è quello di diffidare di chi afferma che tutte le prove supportano la propria visione personale e che non ce n’è nessuna che tenda a disconfermarla. Ogni volta che qualcuno mi dice, a proposito di un argomento complesso (che sia il teismo, il cristianesimo, l’evoluzione o qualsiasi altra cosa), che tutte le prove sono dalla parte della sua visione personale, mi porta a ridurre la mia fiducia nella sua obiettività con i dati, e comincio a pensare che il pregiudizio di conferma sia particolarmente prominente nel processo di ragionamento di questa persona. È una virtù intellettuale essere in grado di ammettere che una o più prove tendono a disconfermare la propria opinione. Naturalmente, presumibilmente si sostiene anche che le prove che tendono a confermare la propria opinione sono più forti, nel complesso, di quelle che tendono a disconfermarla. Tuttavia, riconoscere l’esistenza di dati difficili o anomali è un segno di mentalità esplorativa. E come possiamo determinare se un dato conferma o meno le nostre convinzioni cristiane? Per ogni dato che incontriamo, dovremmo chiederci se quel dato, considerato isolatamente, è più probabile in base al cristianesimo o in base alla sua falsità. Se si tratta della prima ipotesi, si tratta di un’evidenza che conferma il cristianesimo; se si tratta della seconda, si tratta di un’evidenza contraria. Troppo spesso vedo persone ragionare sul fatto che, se un insieme di dati può essere reso compatibile con le loro convinzioni, allora hanno neutralizzato l’obiezione alle loro convinzioni. Tuttavia, questo approccio è piuttosto semplicistico. È quasi sempre possibile rendere compatibili i dati discordanti con le proprie convinzioni. Ma questo non significa che i dati non siano meglio prevedibili se si pensa che le proprie convinzioni sono false piuttosto che vere, o che non si debba diminuire la propria fiducia in quelle convinzioni. La domanda appropriata, quando ci si trova di fronte a dati discordanti, non è chiedere “Posso credere di avere ancora ragione?”. Galef sottolinea giustamente che “la maggior parte delle volte la risposta è “Sì, facilmente”” (p.141). Piuttosto, dovremmo chiederci fino a che punto la fiducia nelle nostre convinzioni debba essere aggiornata in risposta a questi nuovi dati.
Un altro criterio di un apologeta credibile è la disponibilità a criticare le argomentazioni presentate da altri dalla propria parte del dibattito. Sono imparziali nel sottoporre le argomentazioni a favore della propria visione allo stesso esame di quelle presentate da chi sta dall’altra parte del dibattito? Questo rivela che si è capaci di discernimento e che si ha una sincera preoccupazione per l’accuratezza dei fatti. Anche il modo in cui si risponde alle critiche, sia a quelle amichevoli sia a quelle provenienti da voci dissenzienti, è un indice della preoccupazione per una corretta rappresentazione delle informazioni. La capacità di ritrattare pubblicamente affermazioni false o fuorvianti e di apportare correzioni contribuisce notevolmente a stabilire la credibilità di una persona. Quando incontriamo un nuovo contributore al dibattito, con il cui lavoro non abbiamo mai interagito, dovremmo anche verificare le sue affermazioni, risalendo, se possibile, alle fonti primarie, soprattutto quando si addentra in un territorio che non rientra nelle nostre competenze. Se sono in grado di sostenere una storia di affidabilità nel riportare le informazioni e di informare pienamente il pubblico sui fatti rilevanti, si dovrebbe essere più inclini a fidarsi di loro come autorità credibile. Se invece hanno l’abitudine di sbagliare i fatti, si dovrebbe esitare a credere a ciò che dicono sulla parola.
Bisogna anche diffidare degli apologeti che esagerano la forza delle loro argomentazioni, spingendo i dati oltre le loro possibilità. È sempre meglio sottovalutare i meriti delle proprie argomentazioni e sorprendere piacevolmente con un’offerta eccessiva, piuttosto che sopravvalutare i meriti dell’argomentazione e deludere con un’offerta insufficiente. Per questo motivo, negli scritti e nei discorsi pubblici preferisco usare affermazioni dal suono più cauto come “questo tende a confermare” o “questo suggerisce” piuttosto che affermazioni più audaci come “questo dimostra” o “questo evidenzia”. Allo stesso modo, parlerò di “fiducia” piuttosto che di “certezza” delle mie conclusioni.
La mia entusiastica difesa dell’integrità e delle sfumature nell’apologetica, insieme alla mia insistenza nel sottoporre gli argomenti avanzati a sostegno del cristianesimo allo stesso esame a cui sottoporremmo gli argomenti contrari, è stata talvolta fraintesa – sia dagli atei che dai cristiani – come un’indicazione della mia perdita di fiducia nella verità del cristianesimo. Tuttavia, questo non è affatto vero e, francamente, mi rattrista che l’apologetica cristiana sia stata associata, nella mente di molti, a una mentalità da soldato piuttosto che da esploratore. È chiaro che è possibile essere convinti dall’evidenza che il cristianesimo è vero e tuttavia impegnarsi a presentare onestamente le informazioni. È anche possibile credere che il cristianesimo sia ben supportato, pur sostenendo che molti degli argomenti avanzati a sostegno del cristianesimo sono fondamentalmente sbagliati o drammaticamente sopravvalutati. Ritengo che sia una virtù, piuttosto che un vizio, riconoscere i propri pregiudizi di conferma e quindi prendere provvedimenti per ridurne gli effetti negativi sul proprio ragionamento. I principi che ho sostenuto in questo scritto sono fondamentali per gli apologeti di qualsiasi posizione, indipendentemente da quanto siano convinti di tale posizione. Altrimenti, è troppo facile ingannare noi stessi, applicare due pesi e due misure, scegliere i dati in modo selettivo e proteggerci dal rischio di scoprire che siamo in errore riguardo a una o più delle nostre convinzioni.
La disinformazione e una mentalità disonesta non sono giustificabili per gli Apologeti Cristiani.
Naturalmente si può obiettare ai principi sostenuti in questo scritto che, se dati non validi o argomentazioni esagerate portano le persone ad abbracciare il Vangelo, allora il fine giustifica i mezzi. Ricordo di essermi lamentato, in più di un’occasione, della presentazione di informazioni di fatto errate in difesa del cristianesimo presso una società cristiana affiliata all’università nel Regno Unito. La risposta che mi è stata data, purtroppo, è stata che è molto improbabile che altri partecipanti conoscano abbastanza l’argomento per accorgersi degli errori della presentazione, e che dovremmo rallegrarci che abbiano ascoltato il Vangelo. Questo pensiero, tuttavia, è sbagliato per almeno due motivi. In primo luogo, pretendiamo di rappresentare colui che si è identificato come la verità stessa (Giovanni 14:6). Numerosi testi biblici condannano l’uso di metodi ingannevoli (es. Esodo 20:16; Salmi 24:3-5; 101:7; Proverbi 10:9; 11:3; 12:22; 24:28; Colossesi 3:9; Efesini 4:25). Non è quindi onesto nei confronti di Dio perpetuare la disinformazione, anche in difesa del Vangelo. In secondo luogo, se una persona con cui abbiamo condiviso il Vangelo in seguito fa le sue ricerche per determinare se le cose che abbiamo detto sono effettivamente vere, proprio come i Bereani sono lodati per aver fatto riguardo alla predicazione di Paolo (Atti 17:11), siamo responsabili di aver posto un altro ostacolo tra loro e il Vangelo. È una cosa grave di cui essere responsabili.
In sintesi, coltivare una mentalità da esploratore e minimizzare quella da soldato può aiutarci a pensare con maggiore chiarezza e onestà intellettuale alle nostre convinzioni e alle ragioni che ci spingono a mantenerle. Non posso che raccomandare il libro di Julia Galef “The Scout Mindset”. Raccomando anche la sua presentazione per TEDx Talks, “Why ‘scout mindset’ is crucial to good judgment”.
——————————
Note a piè di pagina
[1] Julia Galef, The Scout Mindset: Why Some People See Things Clearly and Others Don’t (New York: Porfolio, 2021).
[2] Dan M. Kahan, “Ordinary science intelligence’: a science-comprehension measure for study of risk and science communication, with notes on evolution and climate change”, Giornale della ricerca sul rischio 20, n. 8 (2017), 995-1016.
[3] Caitlin Drummond e Baruch Fischoff, ” Individuals with greater science literacy and education have more polarized beliefs on controversial science topics”, Processi dell’Accademia Nazionale delle Scienze 114, n. 36 (settembre 2017), 9587-9592.